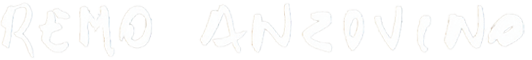Tratto dal Messaggero Veneto – Edizione di Pordenone del 14 luglio 2014.
Quando ho accettato la proposta della Pro Pordenone di tenere un concerto all’alba sul Noncello l’ho fatto sostanzialmente per il sentimento profondo che nutro verso quel luogo. La notte stessa della formalizzazione del contratto per il concerto mi sono subito recato nell’area antistante il fiume dove avrei suonato. Questo per studiare esattamente i suoni che appartengono a quell’ora del giorno, in quel luogo.
Ho scoperto immediatamente che l’area suona benissimo come fosse un anfiteatro naturale, accorgendomi che il suono della mia stessa voce rimbalzava tra l’acqua del fiume e il terrapieno. Ho poi catturato con il mio iPhone i registri dell’orchestra naturale che potevo utilizzare: lo scorrere del fiume, il frusciare dell’erba, il meraviglioso canto degli uccelli, il passaggio improvviso di nutrie e altri animali, l’incedere pigro e ferroso del primo treno regionale verso Udine, quello dei lavoratori.
Ho compreso immediatamente che per rendere davvero omaggio alla mia città avrei dovuto utilizzare solo ed esclusivamente il suono del mio pianoforte a coda senza alcuna amplificazione e senza alcun espediente elettronico. Avrebbero inevitabilmente coperto quei suoni unici. Unici perché fanno convivere alla percezione dell’udito l’anima della mia città, che nasce contadina, si sviluppa sullo scambio commerciale ed esplode, nella sua dimensione post moderna, con il boom industriale. Assieme agli organizzatori e al mio manager, durante il sopralluogo successivo, abbiamo deciso di non mettere a disposizione sedie, né altre comodità tipiche di un teatro tradizionale. E inoltre di non transennare il palco. Il Noncello, per un giorno, doveva essere il luogo di tutti.
Ho composto un’ora di musica divisa in tredici movimenti che dovevano rappresentare la diagonale di un quadrato, ovverosia la linea di una luce che nasce dal buio e che sale, in crescendo, a farsi giorno con mille sfumature. Desideravo alternare momenti di estrema delicatezza ad altri di ancestrale violenza per descrivere quello che per me è l’alba: il momento del giorno nel quale qualcosa nasce e qualcosa muore e che più somiglia all’anima.
Mi ero informato in stazione sull’orario del primo treno, potendo così comodamente sincronizzare la musica al suo passaggio sul ponte della ferrovia, alle 5.09. Ma, nel lavoro prepara- torio di un compositore, di un musicista visuale in particolare, c’è una cosa che non si può prevedere: la luce di bellezza infinita di quattromila occhi, un lago placido, sdraiato a fianco al fiume, colmo di emozione.
Quando, accompagnato dal mio manager ho, a fatica, raggiunto il palco, ho potuto sentire sulla pelle l’amore di duemila esseri umani che avevano sfidato il sonno e ogni sorta di scomodità pur di prendersi quel luogo e quelle emozioni.
Quando ho suonato la prima nota ho sentito sulla pelle tutta la maturità del pubblico che avevo di fronte. D’un tratto il silenzio, quasi irreale, permetteva di trasformare le mie idee in realtà: il suono dell’acqua sembrava una linea misteriosa di contrabbassi e violoncelli di una sinfonia di Mahler, i primi vagiti degli uccelli i flauti e gli ottavini de la Sagra della Primavera di Stravinski, lo sferragliare del treno proprio nel punto della musica in cui l’avevo previsto, sembrava la tromba di Miles Davis in All Blues, il dondolare del respiro del pubblico sembrava quello di Bob Marley in Survival.
La musica era un contrappunto ai suoni che avevo immagazzinato e, cosa difficile persino da spiegare, sentivo ad ogni crescendo della partitura salire il canto degli uccelli che si faceva coro, struggente come quello del Nabucco di Verdi.
Il resto è stato solo musica. La disciplina senza ombra di dubbio più universale, più capace di unire generazioni e parlare dritta al cuore. Sentivo, mentre suonavo l’ultimo bis, che mai più avrei suonato in quel luogo perché credo che certi apici vadano raggiunti presso altre montagne, altri mondi, possibilmente il mondo intero.
La mia valigia è già pronta, come sempre d’altronde, per un altro concerto, un altro disco, un’altra avventura.
Ma credo di non sbagliare se, come ho detto dal palco rivolgendomi al pubblico, penso che la gente è molto più veloce, molto più capace, nell’andarsi a prendere gli spazi e le emozioni che le spettano di diritto: il diritto di preservare le proprie radici, che ritengo siano uno degli strumenti più potenti e a portata di mano per uscire dalla situazione che stiamo vivendo.
E credo che se duemila persone si vegliano all’alba per stare in religioso silenzio di fronte alla loro città e al loro fiume, chi è deputato a decidere debba stare altrettanto in silenzio ad ascoltare con il cuore e con la mente questa pacifica, ma ferma, richiesta di vivere tutti appieno il luogo più bello della nostra terra. E agire di conseguenza.
Remo Anzovino